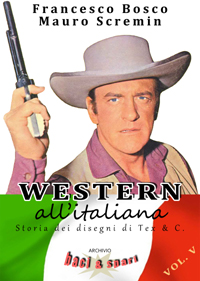
- Fumetto UK
- Fumetto USA
- Fumetto franco-belga
- Noir anni 60
- Anteguerra
- Dopoguerra
- Fumetto sexy
- Libri e magazine
- Autori
- Altri fumetti
- Edicola
- Fanzine

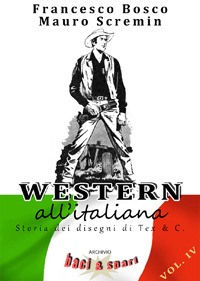
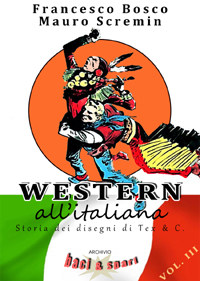
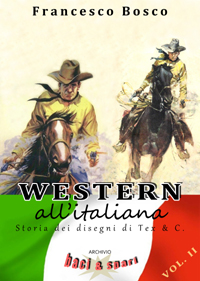
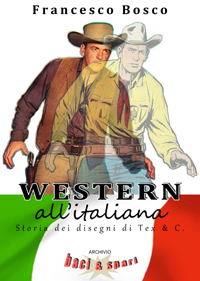
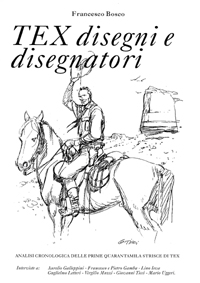


Sei in: Home page > Articoli > La brutta realtà
Articoli
Ivano Marchi e Francesco Bosco [26/06/2025]
La brutta realtà

Nel vasto universo del fumetto, si possono individuare con chiarezza tre ambiti distinti: quello della ricerca e dello studio, quello della discussione critica e infine quello del mercato. Tre settori che, pur appartenendo alla stessa galassia, risultano spesso completamente scollegati l’uno dall’altro, come isole che si ignorano reciprocamente.
Personalmente, mi riconosco da sempre nel primo ambito: quello dello studio, alimentato da una passione autentica e mai venuta meno. Colleziono fumetti da una vita, non per investire o per esibire, ma per comprendere, per custodire e tramandare una memoria. Non ho mai fatto parte, se non marginalmente, del mondo del commercio fumettistico.
Osservando oggi ciò che mi circonda, non posso che provare un certo dispiacere. Vedo sempre meno studiosi o appassionati che si cimentino nella pubblicazione di lavori seri dedicati al cosiddetto fumetto d’antiquariato. Allo stesso modo, sono sempre più rari i momenti di confronto autentico, quelli in cui la riflessione sul fumetto si nutre di argomenti solidi e di un linguaggio consapevole. Ed è un dispiacere forse ancor più profondo, perché proprio il dialogo, il dibattito, dovrebbero essere il motore primo di ogni crescita culturale ,non solo per dar vita a nuovi studi, ma anche per incoraggiare la semplice circolazione delle idee.
La realtà, temo, è che molti di coloro che per decenni si sono spesi per attribuire dignità e credito all’informazione fumettistica hanno ormai superato la soglia dei settant’anni. E il confronto con le nuove leve, i T-Boys, P-Boys, F-Boys , appare, nella migliore delle ipotesi, sfiancante. Non tanto per la distanza generazionale, quanto per l’abissale differenza di linguaggio, di metodo e, soprattutto, di profondità. Per essere chiari: il livello medio di questi “nuovi protagonisti” è così basso da scoraggiare gli alti e solidi coglioni del più paziente degli uomini.
E così assistiamo al trionfo del terzo settore: quello della compravendita, del collezionismo ostentato, del feticismo dell’oggetto fine a sé stesso. Siamo ormai circondati da figure che misurano il proprio valore nel mondo del fumetto attraverso la bellezza esteriore, la rarità apparente o l’integrità quasi chirurgica dell’albo posseduto. La logica dominante sembra essere: “Più il mio albo è intonso, più valgo; più è bello da vedere, più godo… e faccio godere”. Un’esibizione muscolare che richiama più il culto narcisistico della performance che non l’amore per la carta stampata.
Ivano Marchi
Un amico, stamattina, mi ha detto con tono sconsolato: «Francesco, ma com’è possibile che questi grandi esibizionisti, invece di mettere i loro albi a disposizione di chi studia, li sventolino come trofei?». Non ho saputo trovare una risposta convincente, ma mi è tornato in mente quel tizio che, qualche anno fa, non faceva che sommergermi di foto dei suoi albi “da magazzino”. Curiosamente, sparì nel nulla dopo che, con un mezzo sorriso sotto i baffi, gli mostrai una decina dei miei Zagor, messi lì senza clamore.
Forse ci stiamo davvero incamminando verso una forma di roccosiffreidismo collezionistico, dove la misura e l’ostentazione contano più del contenuto. E se da un lato questo scenario può far storcere il naso, dall’altro , almeno , qualche risata riesce ancora a suscitarla.
Beh… mai dimenticare di dare un po’ di profumo alla mutanda con dentro il tuo 1-29, in versione “Alabarda Spaziale” già condomizzato da bustina acid free, al tuo primo appuntamento con lei.
Ma , battute a parte, un tempo lo studio dei fumetti era un’attività profondamente condivisa, quasi comunitaria. Chi si appassionava a una serie o si immergeva nella ricerca di materiali rari sapeva di poter contare su una rete di collezionisti generosi e disponibili. Se avevi bisogno di consultare un albo, un’intera collana o semplicemente verificare un dettaglio editoriale, il collezionista collaborativo non si tirava indietro: ti prestava senza problemi il suo materiale, te lo consegnava a mano o, con grande naturalezza, ti invitava direttamente a casa sua.
Ricordo bene quei tempi. Era il 2000 quando, seguendo le tracce di alcune edizioni di Tex, mi spinsi fino a Napoli. In quella circostanza ebbi il privilegio di visionare collezioni complete e ben conservate, spesso incensurate, custodite da appassionati che mi accolsero con spirito di autentica condivisione. Quelle esperienze mi permisero di raccogliere materiale per un volume che scrissi con passione ma che, per vari motivi, non pubblicai mai.
Anni dopo, nel 2016, un amico mi prestò un consistente numero di romanzi della serie “Grand Hotel Raccolta”, una collezione preziosa e oggi ancor più difficile da reperire. Quei testi furono decisivi per l’elaborazione dei volumi dedicati ai Western all’italiana. Tutto questo testimonia un’epoca in cui la passione per il fumetto non si limitava al collezionismo fine a sé stesso, ma si nutriva di dialogo, fiducia e collaborazione. Oggi molte cose sono cambiate: meno contatto umano, meno scambio diretto, meno storie condivise davanti a una libreria colma di albi letti e riletti. Una stagione forse irripetibile, ma che resta viva nella memoria di chi l’ha vissuta.
Beninteso che gli accalappia-polli esistevano già venti, trenta e quaranta anni fa, alcuni dei quali brillantissimi oratori ancora presenti oggi sul mercato, nonostante una crisi che li ha portati ad eccessi di narcisismo inauditi.
Francesco Bosco

